
Design thinking per modellare il futuro senza temere il cambiamento
Pubblichiamo con piacere un guest post di Puntodock, che terrà un workshop sul Design Thinking per noi giovedì 23 marzo.
Il 70 % dei membri dello staff di grandi aziende italiane dichiara di ottenere risultati migliori quando lavora in team.
L’ 80 % dei dirigenti di grandi aziende internazionali sostengono che le due principali linee di sviluppo per il management futuro saranno design organizzativo per ripensare le imprese a misura di team di lavoro, e design thinking, per riprogettare il lavoro a misura di team collaborativi.
Stando a questi dati e a quanto ci sentiamo ripetere da anni a più voci e a più riprese, possiamo affermare senza dubbio che la contemporaneità impone a tutti di essere attenti alle novità e di sapersi costantemente adattare al cambiamento.
Perché allora la maggior parte di noi ha così paura di ciò che è nuovo?
Ce lo spiega Roger L. Martin in un articolo dal titolo Use design thinking to build commitment to a new idea il quale sostiene che la cultura moderna ci impone di credere a qualcosa solo quando siamo razionalmente convinti dalla sua logica ed abbiamo, in aggiunta, dati che ci diano evidenze empiriche.
Le nuove idee però, per definizione , non hanno dati che ne confermino la validità. Del resto, anche se ci fosse disponibilità di dati, poco potremmo dire su come andranno le cose: le prove analitiche tengono in grande considerazione il passato, ma danno poca o nulla attenzione al futuro il quale, proprio come detto sopra, sarà verosimilmente molto diverso dal passato.
Questa predilezione verso l’analisi del passato spesso si trasforma in un atteggiamento conservativo che sceglie di “sfruttare” quello che ha dato prova di funzionare piuttosto che “esplorare” quello che in futuro funzionerà.
Quindi, non potendo fare affidamento sui dati, per convincere le nuove idee dobbiamo allora contare su altri due elementi: la logica e le emozioni.
Citando il caso studio dello sviluppo di un nuovo prodotto da parte di un’azienda del settore finanziario, Martin descrive come il design thinking fornisca gli strumenti giusti per sviluppare un progetto radicalmente nuovo che sia in grado di convincere chi è chiamato ad attuarlo.
La mancanza di dati sul prodotto, infatti, può essere sopperita da un percorso logico che parte da una solida comprensione dei bisogni e delle preferenze del cliente: le tecniche del design ci consentono infatti di adottare un approccio collaborativo, customer-centric e iterativo, immaginando le storie degli utilizzatori per prototipare, testare e migliorare versioni via via più evolute del prodotto.
In contemporanea i nuovi prodotti devono essere anche “raccontati” dentro all’organizzazione, allo scopo di convincere e motivare le persone: chi è chiamato a sviluppare qualcosa di nuovo lo fa meglio se crede nel progetto e nei vantaggi che questo sarà in grado di produrre.
Un buon modo per raggiungere questo risultato è quello di creare un contatto diretto tra chi si occupa dello sviluppo e gli utenti che vengono coinvolti nella realizzazione dei prototipi di modo che i primi possano percepire le reazioni che questi hanno quando entrano in contatto con il loro lavoro.
“Il successo nel convincere lo staff a credere nelle nuove idee”, conclude il manager protagonista del caso studio, “viene da una combinazione rigorosa delle informazioni provenienti dai piani di business con quelle provenienti dai prototipi”. In questo modo, grazie ai prototipi e con l’avanzare dei test, l’organizzazione è in grado di collezionare nuovi dati che le saranno utili per prevedere come si comporteranno i clienti quando il prodotto andrà sul mercato e a non avere paura di fare un salto nel buio (che poi tanto buio non sarà più).
Andiamo dunque verso un futuro in cui le aziende saranno “network di network” nei quali il valore degli individui sarà sempre di più funzione della loro capacità di interagire e di lavorare in simbiosi con gli altri. Bisognerà costruire squadre perché non basteranno più un insieme di talenti slegati tra loro. Per questo, già a partire da oggi, diventa più che mai necessario trasferire ai team di lavoro competenze trasversali e metodologie necessarie alla collaborazione. Ma non basta questo.
Perché non c’è collaborazione senza organizzazione, e non ci sono organizzazioni senza persone. Nessuno, infatti, conosce l’azienda meglio di chi ne fa parte. Collaborare allora significherà sempre più mettere in condivisione le informazioni, analizzare la realtà e progettare il futuro.
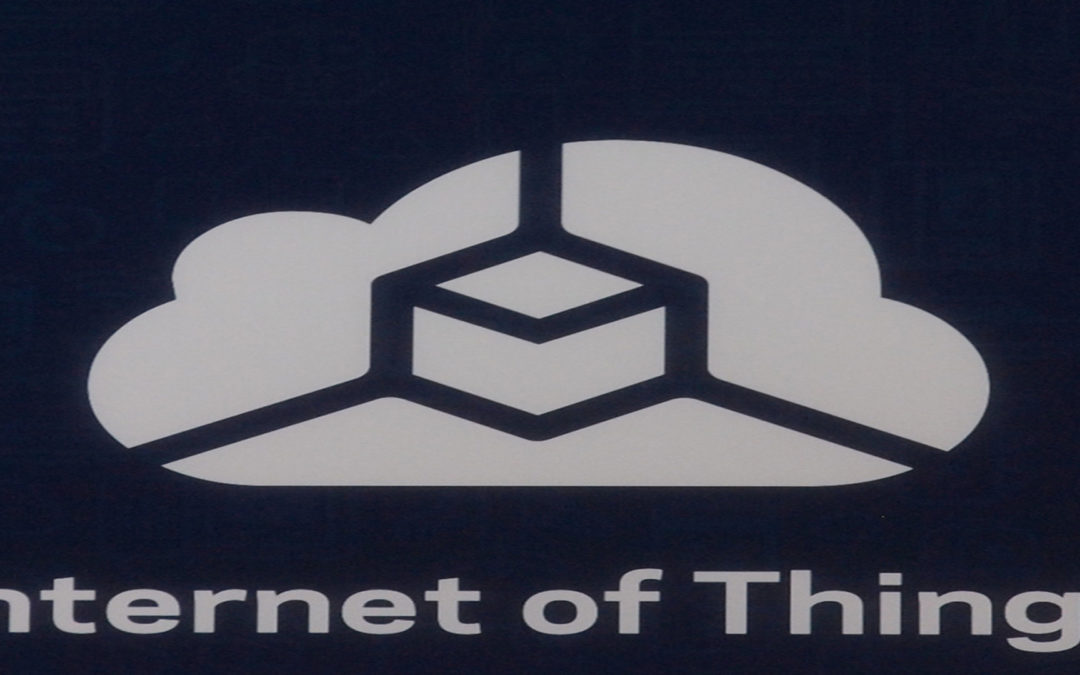
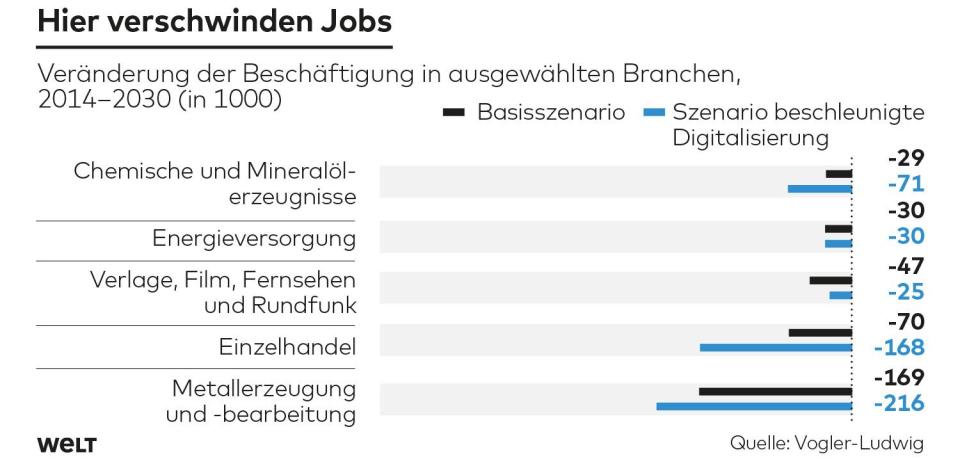
Commenti recenti